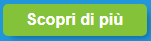21 marzo 2012
Interviste
Fibrosi cistica, malattia genetica che insidia i polmoni
Tags:

La fibrosi cistica è la più comune tra le patologie genetiche, tuttora priva di una terapia risolutiva, ma con cui è possibile convivere più a lungo rispetto al passato: in media 40 anni e oltre. Il paziente, infatti, con cure specifiche, fisioterapia e attività fisica può migliorare la qualità della vita, come spiega in un'intervista Giuseppe Magazzù, presidente della Società italiana per lo studio della fibrosi cistica (Sifc).
Che cos'è la fibrosi cistica?
Si tratta di una malattia genetica associata a mutazioni che hanno come effetto principale il progressivo deterioramento della funzionalità polmonare causato da un'alterazione dei canali cellulari deputati al passaggio di acqua e sali, in particolare del cloro. In pratica, le secrezioni fuori dalla cellule diventano più dense favorendo a livello respiratorio la proliferazione di batteri e quindi infezioni che innescano un circolo vizioso. Ma le conseguenze dell'alterazione si possono avere, in molti casi, anche a livello del pancreas e dell'intestino. Nel pancreas si blocca il canalicolo che lo collega all'intestino, impedendo il passaggio di enzimi necessari per la digestione. L'organo continua funzionare ma non riuscendo a svuotarsi, si infiamma e va incontro a formazioni di cisti e nel tempo può anche perdere la funzione di produzione di insulina portando così al diabete. L'ostruzione può interessare anche i canali biliari che vanno al fegato provocando cirrosi epatica. Infine, in una piccola percentuale di neonati, il blocco dell'ultimo tratto intestinale, l'ileo, comporta una condizione chiamata ileo da mecomio, che necessita di intervento chirurgico per essere risolta.
Come si può curare?
Non esiste una terapia risolutiva anche se non è stata abbandonata l'ipotesi di poter intervenire sui geni mutati. Oggi il trattamento della fibrosi cistica consiste in un approccio che prevede assunzione di antibiotici e di enzimi pancreatici e fisioterapia. In sostanza, si va a intervenire sugli effetti della malattia nei vari distretti. Gli antibiotici sono la risposta alle infezioni respiratorie, somministrati per via orale, endovenosa o inalatoria. La somministrazione inalatoria prevede ora anche una formulazione in polvere che rende più rapida l'assunzione. È importante anche fluidificare le secrezioni particolarmente dense con aerosol di soluzioni fisiologiche o ipertoniche. Grazie alla fisioterapia si apprendono tecniche di rimozione delle secrezioni. I bambini sotto l'anno vanno stimolati con battiture sul torace, mentre dopo l'anno si passa all'uso di mascherine, in cui farli respirare, che stimolano la tosse. Agli adulti si insegnano tecniche per tossire in modo efficace. Per quanto riguarda i problemi digestivi si ricorre alla terapia sostituiva con enzimi pancreatici, altrimenti, soprattutto nei bambini si ha malnutrizione e rallentamento della crescita. Infine, se c'è un insufficienza pancreatica, si crea anche un problema di assorbimento di vitamine liposolubili. Quindi vanno integrate vitamine come la D, la A, la E e la K. Tutti i pazienti devono coadiuvare la fisioterapia con l'attività sportiva sia per il potenziamento della muscolatura toracica, sia per facilitare l'espettorazione delle secrezioni.
Come si segue la diagnosi?
Grazie alo screening neonatale, eseguito per l'individuazione di tre patologie genetiche, oltre alla fibrosi cistica, la fenilchetonuria e l'ipotiroidismo congenito, effettuato ormai in quasi tutte le regioni italiane su tutti i neonati, si ha un primo indizio. Ma è un esame preventivo, non un test diagnostico e si limita a identificare i bambini che potrebbero soffrire di fibrosi cistica. Se il rischio deve essere, perciò, seguito da indagini diagnostiche specialistiche come il test del sudore per la conferma della diagnosi. In un ridotto numero di casi, il test del sudore può dare origine a risultati intermedi o incerti. In questi casi si rende necessaria la conferma diagnostica con la ricerca delle mutazioni genetiche. Dal 1989, infatti è noto il gene responsabile della malattia, ma a oggi sono stati individuati più di 1.900 diverse mutazioni, è possibile che alcune mutazioni rare non vengano rilevate. Ci sono, infatti, pazienti che possono sfuggire allo screening, o magari perché nati prima dell'avvio dello screening, soprattutto se affetti da forme a decorso più lieve che si possono manifestare più avanti. Vanno quindi monitorate persone con problemi o infezioni, respiratori cronici, che con ipersecrezione di catarro, bambini con alterazioni della crescita o malnutrizione, poliposi nasali e pancreatiti croniche, poiché potrebbero essere sintomi di un fibrosi cistica non ancora diagnosticata.
Chi soffre della patologia può avere figli e, nel caso, trasmette la patologia?
In alcuni uomini la fibrosi cistica provoca sterilità poiché i canali che trasportano il liquido spermatico dall'interno all'esterno dell'apparato genitale, sono in genere ostruiti a causa del meccanismo della patologia. Per le donne, invece, la compromissione dell'apparato riproduttivo varia da caso a caso secondo la gravità della patologia. Oggi è comunque possibile avvalersi delle tecniche di fecondazione assistita tenendo presente che è una malattia genetica che si può trasmettere. Ma poiché è una patologia a trasmissione recessiva, se i genitori sono ambedue portatori sani della mutazione, avranno il 25% delle possibilità di avere un figlio affetto da fibrosi cistica per ogni gravidanza. I test genetici possono essere usati anche per la diagnosi prenatale. Si effettua il test sulla madre e, in caso di esito positivo, sul padre. In caso di presenza di un gene mutato in entrambi i genitori, l'amniocentesi o la villocentesi, possono determinare il genotipo del feto.
Simona Zazzetta