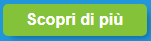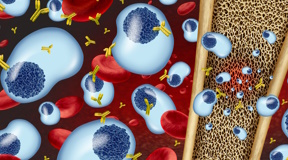Melanoma: cause, sintomi e cure
Indice
Definizione
Melanoma: definizione e generalità
Il melanoma è un tumore maligno della pelle causato della proliferazione incontrollata dei melanociti, le cellule che producono la melanina, il pigmento cutaneo, in risposta alla stimolazione dei raggi ultravioletti (Uv). Tuttavia i melanociti sono presenti anche nell'occhio e nelle mucose per cui, anche se più raramente, il melanoma può insorgere anche in questi tessuti. Il melanoma cutaneo colpisce soprattutto nella fascia tra i 45 e i 50 anni, un'età media che sta progressivamente diminuendo. Secondo l'Airtum (Associazione italiana registri tumori) in Italia si registrano circa 6000 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e le donne, con una crescente incidenza che è addirittura raddoppiata negli ultimi 10 anni. Il melanoma rappresenta circa il 5 per cento di tutti i tumori della pelle.
Cause
Melanoma: cause principali
Diversi studi hanno documentato una relazione tra esposizione a radiazioni UvA e UvB e comparsa di melanoma maligno, soprattutto quando le esposizioni sono state intense e sono avvenute in giovane età. Al contrario sembra che una esposizione cronica o ripetuta a moderate intensità di radiazione solare possa addirittura proteggere il Dna da eventuali danni. I principali fattori di rischio includono la storia familiare, la presenza di nevi displastici, il loro numero e le dimensioni, il fenotipo pelle chiara occhi chiari, uno stato di immunosoppressione dovuto a immunodeficienza o terapie farmacologiche immunosoppressive.
Sintomi
Melanoma: sintomi più comuni
Nella metà dei casi il primo segno di cui si accorge il paziente è il cambiamento d'aspetto di una lesione pigmentata (nevo), già presente oppure comparsa da poco. L'aspetto dei nevi si valuta secondo quattro parametri, abbreviati come ABCD, dove A sta per asimmetria della lesione; B per bordi irregolari; C per colore non omogeneo; D per diametro superiore ai 6 mm o in crescita. Un altro sintomo frequente è il prurito.
Nelle donne insorge più spesso su arti inferiori, cuoio capelluto, viso e collo.
Negli uomini compare principalmente sul tronco.
Diagnosi
Melanoma: come efftuare la diagnosi
La prima ipotesi diagnostica si pone in seguito a visita clinica, in genere dal dermatologo, spesso dopo osservazione delle lesioni con l'aiuto di un dermatoscopio. La certezza della diagnosi si ottiene solo dopo biopsia della lesione ed esame istologico del tessuto asportato.
Altri esami di diagnostica per immagini (ecografia, Tac, Pet) non sono utili per la diagnosi iniziale ma si possono impiegare nelle fasi avanzate della malattia per lo studio delle metastasi.
Cure
Melanoma: cure e rimedi
Il primo fondamentale intervento è quello chirurgico: si deve provvedere all'asportazione del melanoma primario, ovvero di tutta la lesione, anche in profondità, e dei suoi confini. L'escissione chirurgica, infatti, deve comprendere anche un margine di cute e di tessuto sottocutaneo che siano indenni dalla malattia. Stesso approccio si applica, ogni volta che sia possibile, nei confronti di metastasi linfonodali e parenchimali. Le terapie farmacologiche, intese come chemioterapie adiuvanti, da attuare dopo la chirurgia, per prevenire recidive e metastasi sono attualmente poche e poco efficaci.
Prevenzione del melanoma
Il rischio di sviluppare un melanoma è connesso sia a fattori genetici che esterni, e fra questi dobbiamo considerare lo sconsiderato aumento dell'esposizione ai raggi ultravioletti, sia solari che artificiali, la diminuzione dello strato di ozono e la ridotta capacità di filtro dell'atmosfera per il crescente inquinamento ambientale.
La maggioranza dei dati epidemiologici di cui disponiamo indica che il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo è correlato con l'esposizione intermittente al sole, di cui le ustioni solari rappresentano plausibilmente un buon indicatore.
Numerosi studi hanno inoltre rilevato un'associazione tra rischio di melanoma e utilizzo di lampade e/o lettini per l'abbronzatura. Le prevenzione primaria, si attua con le norme per il rispetto della "igiene solare", e la prevenzione secondaria, con il controllo della popolazione in ambulatori specializzati.
Per approfondire...
Di seguito è riportato l'elenco dei principi attivi maggiormente utilizzati nella cura di questa patologia. E' sempre necessario consultare il proprio medico per la scelta di un farmaco, del principio attivo e della posologia più indicati per il paziente.